L’Italia sullo schermo. Come il cinema ha raccontato l’identità nazionale
Roma, Carocci, 2020, 367 pp., euro 32,00
ISBN 978-88-430-9891-0
Data di pubblicazione su web 26/02/2021
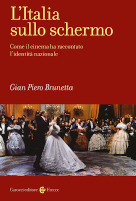
Già nell'Avvertenza Brunetta ricorda il suo pluriennale interesse verso lo studio del cinema come fonte storiografica per la lettura della storia italiana, precisando che «alcuni saggi hanno subito ritocchi minimi, altri sono stati completamente rivisti, ampliati e aggiornati» (p. 13). L'Introduzione si apre con una citazione della giornalista e critica cinematografica Natalia Aspesi che, a fronte dello sconforto per il ridimensionamento dello studio della storia nelle scuole, sottolinea la peculiarità del cinema di non far cadere mai nell'oblio gli errori e gli orrori del passato. Proprio al centro del volume viene evidenziata l'importanza del distacco (temporale e cognitivo) per poter «collocare, in modo più corretto, il testo nel suo contesto, etichettare il film per le idee e le ideologie, le mentalità di cui si fa portatore» (p. 15).
Di notevole interesse è l'analisi delle procedure con cui il cinema degli esordi ha saputo sfruttare il teatro, la letteratura e soprattutto la Storia, a mo' di nano sulle spalle di un gigante (per richiamare la metafora del filosofo francese Bernardo di Chartres). Svincolatasi dalla becera catalogazione di fenomeno da baraccone, la settima arte ha potuto così legittimare la propria nobiltà culturale e assurgere talvolta a vero e proprio “libro di storia” sullo schermo. Muovendosi anche oltre i confini nazionali e adoperando analisi comparate e intertestuali, Brunetta si serve delle fonti archivistiche e documentaristiche reperite quasi esclusivamente presso l'Istituto LUCE di Roma per indagare in maniera diacronica l'identità europea, il divismo, la costruzione del consenso, la guerra e la Resistenza, l'emigrazione, le influenze del cinema italiano all'estero, fino a giungere alle svariate forme di rappresentazione della Storia negli ultimi cinquant'anni.
Nel primo capitolo Brunetta sottolinea l'inclinazione interdisciplinare degli storici tout court ad avvicinarsi alle immagini in movimento, chiamando in causa – ai fini di una maggiormente approfondita lettura delle fonti – metodologie appartenenti ai campi della semiotica, dello strutturalismo e del positivismo. A tal proposito lo studioso sostiene che «il campo cinematografico è diventato sempre più una sorta di vaso comunicante, un contenitore in cui ci sono tantissimi elementi che confluiscono, coesistono, si possono districare, valorizzare e considerare nella loro complessità e interattività» (p. 21). Si aggiunge infine una considerazione sulle molteplici complessità nella comprensione del cinema come linguaggio, considerato un territorio in continua espansione ma che tuttavia stimola i ricercatori ad addentrarsi in zone oscure per scoprire cose impreviste.
Entrando nel vivo dell'iter preannunciato, il volume propone un saggio sul Risorgimento al cinema dall'età giolittiana e fascista fino a quella repubblicana e contemporanea. Passando in rassegna le principali pellicole sull'argomento, Brunetta compie un'intelligente suddivisione tematica ed estetica in base alla vena eroica dei personaggi; a quella sentimentale; a quella legata alla continuità tra passato e presente (in particolare in epoca fascista); a quella nostalgica e a quella narrata dal punto di vista dei vinti, come ad esempio i briganti filoborbonici del Meridione o gli stessi eroi tragici, delusi e rammaricati, di Noi credevamo di Mario Martone (2010), con la struggente conclusione del personaggio di Domenico (Luigi Lo Cascio): «Eravamo tanti. Eravamo insieme, il carcere non bastava: la lotta noi dovevamo cominciarla quando ne uscimmo. Noi, dolce parola. Noi credevamo…» (p. 62).
Dopo aver affrontato il divismo femminile degli anni Dieci ne L'irresistibile ascesa di Giuditta, il critico giunge a un'attenta riflessione sul portato propagandistico del nuovo medium durante la Prima guerra mondiale. In tale contesto il cinema è utilizzato come vera e propria macchina di consenso, fino al momento in cui «il grande pubblico, bombardato ogni settimana da immagini e racconti di guerra, subisce un processo rapido di adattamento, assuefazione e rifiuto di immagini» (p. 90). Acuto osservatore anche dei fenomeni sociologici, Brunetta si addentra in un'analisi minuziosa dei processi migratori di cineasti e maestranze italiane alla volta del Nuovo Mondo, influenzando le abitudini e l'immaginario americano sia dal punto di vista sociale sia da quello più prettamente cinematografico.
In Divismo, misticismo e spettacolo della politica vengono indagate le modalità con le quali il mezzo cinematografico è riuscito a edificare il mito di alcune tra le principali figure politiche del Novecento: da Mussolini a Hitler, da Stalin a De Gaulle. Sempre rimanendo nel contesto fascista, L'ora d'Africa del cinema italiano si focalizza sull'importanza dei documenti LUCE sulla «benefica luce di civiltà che il fascismo fa scendere sulle terre africane» (p. 176). L'excursus bellico continua nei successivi capitoli dedicati rispettivamente alla guerra civile spagnola e alla Seconda guerra mondiale. Di grande valore la minuziosa analisi del periodo della Ricostruzione in una vera e propria ricerca dell'identità-umanità perduta tra anni Quaranta e Cinquanta: da Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luigi Comencini, Carlo Lizzani, Pietro Germi e Alberto Lattuada, giungendo a Luciano Emmer, Luigi Zampa e ai film con Totò, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi e Vittorio Gassmann.
In Cinema come autobiografia e memoria di una civiltà al tramonto, Brunetta definisce la settima arte come luogo in cui «miliardi di persone […] hanno trascorso un tempo importante del proprio vissuto, segnato da emozioni, empatie, pulsioni, transfert, desideri, traumi, sogni e passioni» (p. 289). Segue un'analisi delle cause della crisi delle sale risalente agli ultimi decenni, complice la proliferazione massiva di emittenti televisive ma anche una crisi di idee e di coraggio sia negli sceneggiatori che nei produttori (da tenere sempre a mente che un certo Federico Fellini non riusciva a trovarne per produrre i suoi ultimi progetti).
In chiusura, con Opere-mondo e cantori della storia d'Italia del Novecento si tratteggia il percorso che alcuni tra i più grandi autori del cinema italiano (ma anche del mondo) hanno compiuto nel cantare le donne, i cavallier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese a partire dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri: da Francesco Rosi a Bernardo Bertolucci, da Elio Petri a Ermanno Olmi, dai fratelli Taviani fino a Marco Tullio Giordana. La trattazione di questo labirintico dedalo di viuzze politiche, ideologiche, economiche e oscure, della produzione artistica nostrana, deve renderci tutti fieri del nostro cinema, al pari dell'inestimabile eredità rinascimentale che così bene ci contrassegna. Brunetta incastra nel mosaico della sua bibliografia un altro imprescindibile tassello.
Indice
Avvertenza
Introduzione
Il cinema racconta la storia e le storie dell’Italia unita
1. La storia al cinema finalmente s’è desta
Cinema luogo comune e fonte privilegiata della storia del Novecento
Una storia di storie
2. Il Risorgimento: un’unità problematica e non condivisa
Il Risorgimento, luogo di memoria privilegiato del cinema italiano
La presa di Roma in sette quadri viventi, più veri del vero
Fare l’Italia
I profumi, le luci e le ombre dell’Ottocento
Fuochi di una rivoluzione che non c’è
Un Risorgimento per ogni stagione politica
3. L’irresistibile ascesa di Giuditta sullo schermo Liberty
E lucevan le stelle
La nuova Eva
4. Cinema e Prima guerra mondiale
La nuova arma: il cinema e la propaganda
La memoria ritrovata
Forze in campo e logistica della percezione
Lo schermo e la platea
5. Effetto Caporetto
Italienische Überlaufer
Altri tasselli degli archivi europei
La mobilitazione industriale in Italia
6. Emigranti nel cinema italiano e americano
Memorie al di là dell’Oceano
Verso le Terre promesse
I passi e il cammino dell’emigrante italiano
Non solo un popolo di mafiosi, pugili, cantanti, pizzaioli…
7. Divismo, misticismo e spettacolo della politica
Dopo Dio viene Lui
Monumenti/documenti
Il corpo e le maschere di Mussolini
Hitler e Stalin, dittatori come cineasti
Pio XII e Franco crociati della fede
De Gaulle, pontifex del passaggio dal cinema alla televisione
8. L’ora d’Africa del cinema italiano
Il ritorno di Roma
La via coloniale del cinema italiano
I cantori di una nuova epopea
9. Con i fascisti alla guerra di Spagna
La più bella sorte
La Spagna come teatro di prova generale della Seconda guerra mondiale
Una missione da compiere
10. Un’arma di serenità
La parabola del racconto di guerra
La Repubblica di Salò e il regno del silenzio
11. Cinema ambasciatore italiano nel mondo
Il sogno degli Stati Uniti d’Europa
Lo sguardo telescopico degli Stati Uniti sull’Italia
E un giorno Roma città aperta esplose sugli schermi di tutto il mondo
12. La ricerca dell’identità nel cinema italiano del dopoguerra
«E quindi uscimmo a riveder le stelle»
Palingenesi delle macerie
Alla riscoperta del paese
Il cinema e la politica di potenza
Fra ricerca dell’identità nazionale e americanizzazione
Perdita di memoria e doppio viaggio alla scoperta del Sé e dell’Altro
Fattori e caratteri del nuovo ritratto dell’italiano
Il doppio volto dell’America
La colonizzazione imperfetta
Lo sguardo europeo di Rossellini
Finalmente un film italiano!
Nuovi ritmi, nuovi metri tra guerra e pace
Le mille e una Italia
All’ombra del campanile e oltre
Totò, uomo di mondo
Il gioco delle maschere di Alberto Sordi tra vecchio e nuovo
Passaporto per l’Europa
Alla ricerca della penisola che non c’è
13. Cinema come autobiografia e memoria di una civiltà al tramonto
Splendor, la sala come mondo
Cinema/vita
14. Opere-mondo e cantori della storia d’Italia del Novecento
Mosaico di tessere interconnesse e distinte
Il cinema indaga e processa i misteri della storia
Francesco Rosi e i tempi del Sud
Bernardo Bertolucci e la storia raccontata in nome del padre
Ermanno Olmi e la memoria della civiltà contadina
Paolo e Vittorio Taviani e la storia come epopea e utopia
Microstorie e poemi eroicomici della piccola borghesia novecentesca
La fucina di Pupi Avati, erede dei cantastorie popolari
Marco Tullio Giordana: le ferite, il dolore e le speranze della meglio gioventù
Il cinema di Nanni Moretti come diario generazionale e voce di alto richiamo civile
Stringere la storia di un’immagine
Bibliografia
Indice dei nomi
