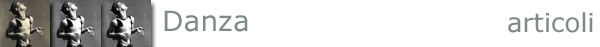|
Citerone è il monte sacro a Dioniso nonché
il titolo della prima parte del breve spettacolo bipartito che Michele
Ifigenia Colturi propone alla XXX edizione di Fabbrica Europa. Mentre il
pubblico fa il proprio ingresso nel Teatro Cantiere Florida, uno dei luoghi che
ospitano il festival fiorentino, due danzatrici a torso nudo sono impegnate a
segnare sul piano del palco sagome e confini con un nastro adesivo rosso.
Il
mondo greco, culla del teatro
occidentale, continua ancora oggi a sostanziare la performance contemporanea,
si pensi – tra vari esempi – al lavoro di Enzo Cosimi. Ma di quel mondo
quest’ultima stravolge la forma, il linguaggio, il significato, rendendolo
attuale ma – spesso – anche irriconoscibile. È il caso di Citerone,
ispirato a Le Baccanti di Euripide, tragedia appartenente alla
trilogia formata da Alcmeonte a Corinto e Ifigenia in Aulide.
Michele Ifigenia, nomen omen, e la sua compagnia Tyche propongono una
rilettura che tuttavia, in mancanza del foglio di sala, forse mai avrebbe riportato
alla memoria le baccanti.
La
coppia di danzatrici mira a
rappresentare la collettività delle donne salite sul monte Citerone per
celebrare il dio del teatro. Queste baccanti indossano scarponi e pantaloni
molto moderni e si muovono all’unisono in maniera concitata, a ricordare sia
l’estasi dionisiaca sia – essendo solo in due – la progressiva perdita di
importanza del coro nel teatro greco. Se il seno nudo fa riferimento ad alcune
immagini della statuaria classica, altri elementi sono forse eccessivamente
anacronistici o rischiano di banalizzare e appiattire il rito. Si pensi ad
esempio alla scena finale, probabile richiamo al banchetto, quando le due
danzatrici siedono una di fronte all’altra ai due capi di un tavolo e mangiano
un panino con nonchalance.
Molto riuscita risulta invece la performance
di Federica D’Aversa che, nella seconda parte del lavoro, interpreta la
Sibilla Cumana esprimendo con rispetto un’essenza sfaccettata, complessa,
misteriosa e archetipica. Sacerdotessa di Apollo, altra faccia del binomio
apollineo-dionisiaco, la Sibilla di Cuma è presente in diverse opere
letterarie, dall’Eneide di Virgilio alle Metamorfosi di Ovidio,
fino a Dante Alighieri. Il coreografo la propone qui nel momento
culminante della profezia, immortale ma consumata, illuminata di conoscenza ma
potenzialmente orrorifica. Nel continuo mutare di un corpo completamente
prestato alla messinscena, Cuma sfrutta in particolare il gioco di luci.
L’illuminotecnica è di fatto parte integrante della drammaturgia e valorizza la
personificazione della Sibilla: dalla eburnea bellezza virginale a un terribile
grido senza voce che sembra accogliere in sé tutto l’orrore del mondo.
|
 |