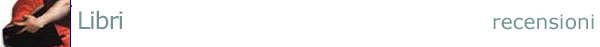|
Continua
il recupero di opere sparse di Antonin
Artaud, esercizio tardivo che pure può offrire nuova intelligenza a
un’opera quasi insondabile. Poi destinata inevitabilmente a mutamenti nelle
traduzioni, come per lo stesso testo è accertabile nella precedente versione di
Pasko Simone (Il melangolo, 2003).
Accostando
queste prove d’ambito e periodo surrealisti (fra il 1925 e il 1928) e
assemblate sotto titolo unico nel 1929, vale controllare il senso che la
nozione di surrealismo assumeva in Artaud, in rapporto alla sua collocazione
nel Gruppo e alla collaborazione sia con «La Révolution Surréaliste», sia con
altre Riviste che ospitarono le sue prose poetiche, come «La Nouvelle Revue
Française» o la «Revue européenne». Lo sfruttamento del sogno, con la tecnica
della trascrizione diretta di stati e immagini onirici, come richiesto dalla
presunta ortodossia di André Breton
e Philippe Soupault, non accomunava
tutti i seguaci e imitatori. Artaud, dopo avere denunciato drammaticamente
l’alterazione del suo stato psico-fisico nello scambio con Jacques Rivière (Correspondance, 1923-1924), avrebbe
prodotto i “drammi mentali”, esemplari della sua visionaria perizia
compositiva. A orientare il poeta nel processo creativo subentrava l’illogica,
sua coniazione, distintiva e a contrasto con l’idea surrealista corrente (unicità
qui segnalata da Giorgia Bongiorno
nella prima Nota introduttiva). Per Artaud il governo sull’immagine,
inconscia o meno, spettava allo Spirito, alla Conoscenza, finalizzati a
superare la letteratura con l’immersione in una vita sempre in fase di rinascita.
Sono
otto i brani della silloge, nei quali s’evidenzia la temperie linguistica di
quell’avanguardia, benché i moventi dell’autore sorgano da profondità inaudite
e nutriti fino all’ultimo dallo strazio fisico del corpo e dalla sovraeccitata
tensione della mente.
«Chi,
nel cuore di certe angosce, in fondo ad alcuni sogni, non ha conosciuto la
morte come un senso di rottura e meraviglia con cui nulla si può confondere nel
mondo mentale?», è l’incipit
del libro (e del brano) che veniva presentato in una conferenza alla Sorbona
nel marzo 1928. Nella descrizione fantasticata della morte, anche il sogno
appare in qualche sorta un prodotto mentale. Il contatto originale si vorrebbe
recupero dello stato infantile: «In certe paure paniche dell’infanzia, certi
terrori grandiosi e irragionevoli dove cova la sensazione di una minaccia
extra-umana» (p. 30) si pongono come presupposti da riconoscere ed elaborare,
ma in condizione d’impotenza, tale quella confessata a Rivière: «Qualsiasi cosa
tu faccia, non hai ancora cominciato a pensare» (p. 28). Man mano, Morte
e Amore si fanno ossimoro. Nell’indirizzo alla Veggente (la vera Madame Sacco),
lo scrittore stabilisce un’intimità affettiva: «Davanti alla veggente avevo
questa sensazione: la vita era bella perché c’era lei» (p. 38). Processo di
proiezione e identificazione che l’autore praticherà spesso e soprattutto con
le donne elette platonicamente sue muse.
Il
dittico dedicato ad Abelardo ed Eloisa insegue, molto articolato e
forse incompiuto, il fenomeno di sublimazione di pulsioni sessuali e
aspirazioni trascendenti. I toni cercano equilibrio fra drammatiche
constatazioni e giudizi sarcasticamente critici e disturbanti, in reazione alla
tragica evenienza, la castrazione, «che pesa – a dirla con Artioli – come un fatto mentale che inibisce il desiderio» (Teatro
e corpo glorioso, 1978, p. 31). Così si scontrano gli stati, sempre
immaginari, ma rifluiti da esperienza esistenziale. Sessualità e sublimazione
interagiscono nel linguaggio che osa fondere fisiologia, filosofia e meccanica
del pensiero. Accostamenti lessicali arditi causano immagini, ora verbali ora
visive, tipiche d’un gesto creativo rischioso nell’artificio spinto al
manierismo. Un esempio: «La vita va e viene e cresce piano sotto il lastrico
dei seni. Intorno alle dita si arrotolano le anime con le loro crepe di mica, e
tra la mica Abelardo passa, dato che l’erosione dello spirito sovrasta tutto»
(p. 43).
Ciò
di cui si compiaceranno i surrealisti, sarà per il poeta sempre più oggetto di
reazione e di rifiuto alla convenzione letteraria. Nel grido «sono nato dal mio
dolore» si ancorerà la tensione futura verso un linguaggio sempre più autentico
poiché “inventato”, segno della propria conflittuale intimità. L’avventura
della coppia storica è attraversata da un’alterazione metaforica e da
acquisizione di risonanze e corrispondenze simboliche, quando il finale
concentra, nel crogiuolo alchemico, piacere orgasmico e coscienza
dell’evirazione violenta: «E grida Abelardo, divenuto come morto... con la
punta vibrante e all’apice dello sforzo... Allora la latteria celeste si
esalta... il ventre chiuso, sente la verga diventare liquida» (p. 46). Aspetti
carnali e metafisici si ritrovano in Abelardo il Chiaro: guidato da
razionalismo esasperato, ma succube della seduzione carnale, lo scrittore fa
del suo eroe (ancora coinvolto in una variante dell’amplesso) un nuovo alter
ego.
L’atteggiamento
si ripete nella meditazione sul pittore Paolo
Uccello, all’alterità del quale si affida in Uccello, il pelo. Oltre
che germe di teatralità (per dramma mentale), il testo isola particolari
anatomici in ossessivo rilievo: «Uccello, amico mio, mia chimera. […] L’ombra
della grande mano lunare non ti sfiorerà mai la vegetazione dell’orecchio. […]
A sinistra i peli, Uccello, a sinistra i sogni, a sinistra le unghie, il cuore»
(p. 35). Il poeta ruba al pittore le immagini e dalla tela le trasferisce sulla
pagina, campo d’una battaglia epica quanto quella d’un quadro, partecipata per
tormento uguale: «Eri nato con la mente vuota quanto la mia, lo so, ma quella
mente hai potuto fissarla su poche cose […]. Con la distanza di un pelo,
oscilli su uno spaventoso abisso» (p. 57).
Lo
sguardo allucinato sull’opera di André
Masson frutta poi L’incudine delle forze, ove il ritmo verbale
risponde al ritmo visivo delle immagini evocate: «Questo flusso, questa nausea,
queste strisce, è da questo che comincia il Fuoco. […] Ho assenza di
meteore, assenza di mantici infuocati. […] L’umore leggero e rarefatto. Anch’io
aspetto soltanto il vento» (pp. 61-64).
L’ultimo
brano è più divertito aneddoto, o vaudeville, con personaggi letterari
trattati con scherno e ironia. L’inizio è in falso stile bohémien:
«L’amavo. Faceva la serva in una taverna di Hoffmann, ma era una squallida e
abietta servetta» (p. 75). Poi l’andamento teatrale o narrativo sfoggia impulsi
e immagini contrastati, espressioniste oltre che surreali. Un fotogramma
laconico, il finale: «Una luce da fine del mondo riempì poco a poco il mio
pensiero» (p. 80).
di Gianni Poli
|
 |