Jean Vilar, une biographie épistolaire
A cura di Violaine Vielmas
Arles, Actes Sud-Papiers, 2023, 432 pp., 27,00 euro
ISBN 978 2 330 18019 5
Data di pubblicazione su web 11/09/2023
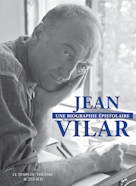
L'attività dell'attore, regista e direttore francese è stata accompagnata da un'incessante intensa corrispondenza che ne caratterizza la personalità e ne mostra i tratti tipici più intimi. Introducendo molti inediti, accanto a lettere già pubblicate, l'opera curata da Violaine Vielmas intende tracciare una biografia insolita, ma fedele e coerente, dell'inventore del Festival d'Avignon e del maggiore testimone e interprete dello spirito del Teatro Popolare. Vilar fu «un acteur et un témoin de la vie culturelle française. Ces lettres exposent les différents visages de Jean Vilar», personaggio via via identificabile quale «patron, artiste, réformateur, ami» (p. 8).
I documenti vilariani, divisi in istituzionali e personali, sono depositati negli Archivi di Stato e in quelli del Festival avignonese. Le duecentosessanta lettere riprodotte sono scelte fra le più rappresentative nei contatti dell'autore con personalità dell'arte, della cultura e della politica. L'andamento cronologico – dal 1943 alla morte nel 1971 – scandisce in quattro parti l'intera carriera del protagonista, in un confronto che spesso s'arricchisce dell'intervento dei suoi interlocutori. Nell'uomo che aspirava alla dignità di scrittore, lo stile nasceva dalla necessità primaria di raggiungere lo scopo comunicativo. Come in un diario annotava sentimenti immediati e concetti elaborati, senza preoccupazioni formali.
La curatrice riscontra la «conscience aiguë d'une œuvre à accomplir et la volonté de donner, par celle-ci, un sens à sa vie» (p. 11), sorta in concomitanza con la morte del fratello Lucien (1939) e subito annotata con le parole del dolore e del lutto. Per testimoniare la propria esperienza, l'autore poi maturo si sarebbe confidato con un Journal e dedicato al romanzo autobiografico, Chronique romanesque (1971). Testo sottovalutato, che nelle metafore e nel protagonista in cui si specchia l'autore potrebbe illuminare le «attitudes et aspirations contradictoires qui animèrent Vilar au cours de sa carrière» (p. 36). La frequentazione di Jean Paulhan (sua la lettera di apertura, febbraio 1943) e la lettura di André Malraux guidano il giovane Jean dalla natia Sete a Parigi, dove, apprendista régisseur alla scuola di Charles Dullin, l'arte dell'attore gli appare l'ideale d'una visione teatrale da perseguire come vocazione assoluta.
La ricerca d'uno scopo radicalmente impegnativo si manifesta nelle prime relazioni, sincere e già severe: «Le théâtre à l'heure actuelle vous oblige à un combat contre nature. […] Travailler pour trois cent personnes, alors q'il faudrait travailler pour la foule! C'est un peu ridicule, quand on y pense» (p. 47). I legami si tessono con l'editore Gallimard, con Paulhan e con Schlumberger, che gli riconosce una «pureté intransigeante» (p. 45); con il Sartre filosofo e drammaturgo, per radicarsi poi negli attori e nei tecnici delle troupes da lui formate e dirette, La Roulotte e la Compagnie des Sept (anni Quaranta), fino al Théâtre National Populaire.
Camus e Sartre intervengono diversamente nel dialogo e nel
destino dell'impresa vilariana: il primo, valutato in base alla creazione di Le
Malentendu (1944), «une excellente pièce… Une grande œuvre manquée» (p.
52). Il secondo, investito da polemica memorabile sul vero significato di théâtre
populaire, inseguito nella sua ambiguità forse imprendibile. Quando Sartre
misconosceva, in un'intervista, l'autenticità “popolare” del TNP, il direttore
sfidava l'intellettuale con l'invito rinnovato di concedergli un suo dramma per
l'allestimento (a J.-P. Sartre, 1955). Vilar aveva già espresso un
giudizio su Huis Clos, per l'interpretazione di attori che «humilient la
condition de comédien: ils oublient qu'il existe une grammaire, un vocabulaire
et une sintaxe du comédien, dûment refaite et choisie» (p. 52) e s'adattano a
intrattenere un pubblico abâtardi.
Il bisogno di cimentarsi con la drammaturgia contemporanea spinge il regista a sforzi ripetuti di scambio con gli scrittori. Confessa a Paulhan la delusione nel dovere constatare la rarità dei romanzieri che affrontano il teatro, «alors que nous avons tellement besoin d'un poète dramatique. C'est bien triste» (p. 56). Sono naturalmente frequenti gli squilibri nei rapporti interpersonali, fra il patron e i suoi interpreti. Tra i preferiti, spiccano le personalità di Casarès o di Philipe; di Sorano o di Wilson: fonte di tensioni e dialoghi sinceri, pur sempre in toni di raffinata, educatissima amicizia. Il richiamo del direttore alla puntualità, ad esempio, è segno scrupoloso d'un perfezionismo intransigente, in un'etica della fedeltà, percepibile nella ripresa di Lorenzaccio, affidata alla regia di Philipe (giugno 1958), al quale raccomanda di non esigere dai compagni «plus que ses moyens ne peuvent donner» (p. 236).
La profonda implicazione con Casarès si avverte sia nel gioco d'una specie d'intervista reciproca che Vilar promuove, in «un dialogue. Sur le métier de comédien. Ou sur le comédien» (p. 223), sia nello scambio-confessione con la stessa (interprete di Marie Tudor), in uno slancio di riconoscenza: «Te dirai-je un jour tout ce que tu a apporté aux filles et aux garçons de la troupe? Cela est considérable, Maria, plus encore que cette merveille de théâtre que tu es» (p. 239). Lo slancio si prolunga, applicandosi al gruppo per l'allestimento di Mère Courage, ripreso a Ginevra nel 1959: «Vous jouez aussi pour le TNP une partie de prestige» (p. 257).
Vicende pubbliche e divergenze di interessi personali fanno registrare nell'ottobre 1959 uno scontro esacerbato in cui Vilar coinvolge Barrault. La stima reciproca, nella schiettezza del rapporto, diventa conflitto attorno a distinzioni e rivendicazioni riguardanti le risorse disponibili per le relative imprese (pp. 260-265). L'interesse alla nuova drammaturgia si concreta nel sollecitare autori quali Cocteau, Gide e Giono; poi Adamov, Beckett, Ionesco, Genet, Queneau, Anouilh. Ma anche il ricorso a un lettore dedicato, Georges Perros, non produce le scoperte attese. I rapporti con i critici risentono di componenti sia estetiche sia etico-politiche, verificabili nei contatti con Roland Barthes e J.-P. Sartre, Bernard Dort e Jacques Lemarchand. Fra i sostenitori istituzionali, Jeanne Laurent spicca per la comprensione e la generosità collaborativa; André Malraux per l'amicizia e l'apprezzamento, mantenuti fra burocrazia e gusti intellettuali condivisi.
Quanto ai numerosi inediti (affiancati da un inserto illustrativo fuori testo), se il loro apporto non cambia né l'essenza né il valore dell'avventura artistica e riformatrice già nota, assieme contribuiscono a renderla più consona alla misura complessa e discussa nell'ampia storiografia. Ne beneficia certo la consapevolezza d'una memoria consolidata in coerenza con i fatti e i giudizi. Persino sul Festival d'Avignon s'incontrano documenti capaci di precisarne le condizioni di ideazione e d'attuazione. Certe annotazioni (a Maurice Coussonneau, agosto 1947) confermano le doti organizzative e relazionali dell'artista nella progettazione tecnica ed estetica, mediante organici degli interpreti e funzioni tecniche, accanto a criteri gestionali verificabili in manifestazioni internazionali analoghe. Segno di lungimiranza e comunione per obiettivi comuni, in situazioni culturali e operative finora distanti e discordi, come avveniva fra Parigi e la provincia. Per il Festival, la svolta data dalla contestazione del Sessantotto è riflessa in una lettera di Beck e Malina (del Living Theatre) e nella risposta di Vilar: «Abandonnez-moi à mes libertés, comme je vous laisse aux vôtres» (p. 360).
L'ultima lettera – destinata a Malraux (16 maggio 1971) e non spedita – sul senso della responsabilità di Vilar verso il TNP, sentita insostenibile e sui rapporti fra potere, cultura e creatività, non avrà quindi risposta. La Storia stessa sembra dilazionarla, poiché la curatrice soggiunge ulteriori domande: «Peut-on s'engager sans se corrompre? Comment surmonter l'opposition indépassable d'un théâtre populaire dans une société inégalitaire?» (p. 37).