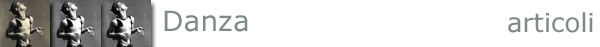|
Mentre
il teatro è ancora semivuoto, quattro figure vestite di bianco giacciono sul
piano del palco attorno a uno strumento elettronico; tre di loro indossano un
visore VR. La foschia che avvolge i performer
e il pubblico richiama gli atti bianchi del balletto romantico ma del balletto
niente rimane se non, appunto, il colore bianco. Improvvisamente una luce al
neon irrompe nel buio, un suono sordo nel silenzio; i tre danzatori con gli
occhi celati dal visore e con i corpi collegati tramite cavi allo strumento
elettronico si muovono a scatti, come automi. Il quarto personaggio continua invece
a giacere inerme al suolo.
Brandon
Lagaert, a sua
volta performer della compagnia belga Peeping Tom, propone insieme a Equilibrio
Dinamico Dance Company una riflessione sul rapporto tra uomo e tecnologia. Come
lo stesso coreografo afferma durante il talk che segue lo spettacolo, il
progresso tecnologico è un pretesto per suscitare domande in tema di gerarchie,
giochi di potere, relazioni interpersonali. Quello che emerge da Welcome to my funeral è infatti il contrasto tra l’appartenere a
un gruppo e la solitudine. Il titolo è programmatico: indica da una parte la
fine del mondo come conseguenza di un futuro eccessivamente votato alla
tecnologia e dall’altra l’inizio di un nuovo modo di vivere. Quello che più
turba nel racconto di Lagaert e di Equilibrio Dinamico è l’impossibilità di
optare per una via di mezzo: o si è dentro o si è fuori.
Tale opposizione emerge fin dall’inizio della
performance, quando i tre personaggi “mascherati” introducono il quarto
individuo al mondo virtuale. Tutti sembrano de-umanizzati, coperti quasi
interamente da tute bianche che richiamano i costumi del film L’uomo
che fuggì dal futuro (George Lucas, 1971), con il viso celato
come i protagonisti di Ready Player One (Steven
Spielberg, 2018) e privi – in un certo senso in linea con i tempi che
corrono – di identità sessuale. Il pubblico, privo di visore, non può fruire di
quel mondo e si chiede che cosa vedano “in realtà” i performer, a quale universo altro abbiano accesso. Solo più tardi si accorgerà
che i visori sono finti: la realtà virtuale non trova spazio “concreto” durante
la messinscena ma è stata utilizzata – dichiara il coreografo – come elemento
attorno al quale sperimentare la creazione coreografica.
Un momento dello spettacolo
© Stefano Sasso La narrazione ruota tutta intorno all’entrare e
all’uscire dalla realtà virtuale. Chi si priva del visore, per volontà, per
distrazione, per incidente o perché obbligato, prende coscienza dell’artificio
al quale ha partecipato – ignaro – fino a quel momento. Prima si dispera e poi
cerca di “aprire gli occhi” ai compagni ma è destinato a un’esistenza di
solitudine, alla visione di orrori che nel mondo virtuale paiono (almeno
superficialmente) non esistere. Chi indossa il visore sembra infatti vivere in
un mondo che suscita curiosità, immune al dolore fisico, anche quando i performer imbracciano fucili immaginari e prendono parte a quella che sembra
essere una guerra. Per chi indossa il visore, anche il modo di relazionarsi è
nuovo e diverso: due dei personaggi tentano un approccio affettuoso, visore
contro visore; riescono a interagire ma i loro visi, con quella sorta di
protesi davanti agli occhi, non riescono a toccarsi.
Nella realtà virtuale tutto si può modificare e
ricostruire da zero. Ma quel mondo, prima immaginato e poi disegnato e vissuto,
rischia il disfacimento: chi ne esce mostra evidenti segni di straniamento, di
paura; vuole distruggere il fittizio e riappropriarsi delle proprie peculiarità
e delle emozioni così come le conosciamo nel mondo “analogico”. La mancanza di
comunicazione tra “dentro” e “fuori” rischia di sfociare in una spaventosa
distopia in cui chi non si evolve – tecnologicamente parlando – rischia
l’estinzione. Particolarmente significativo, anche se apparentemente giocoso,
il fatto che i danzatori prendano gli applausi conservando movenze robotiche.
Tanti gli elementi che hanno ispirato la
coreografia: il cinema (si pensi anche a Blade Runner di Ridley
Scott, 1982, o a Matrix di Andy
e Larry Wachowski, 1999), il mondo della robotica, del videogioco, ma
soprattutto il background del
coreografo e degli interpreti, la fusione di diversi stili di danza,
specialmente la danza urbana, che emerge con prepotenza – e con virtuosismo,
grazie alle doti del danzatore Alessandro Ottaviani – nel risultato complessivo
del lavoro. Se non troppo ricercata e sperimentale, la coreografia appare
assolutamente gradevole alla vista, capace di sintetizzare ciò che è di
tendenza non solo nella danza contemporanea ma, soprattutto, nel mondo
dell’intrattenimento. Welcome to my funeral riesce così a essere accessibile e
comprensibile a un pubblico potenzialmente più vasto e, si spera, più
consapevole dei rischi tecnologici in materia di socialità.
|
 |