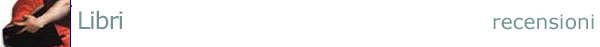Marco Bertozzi
Documentario come arte. Riuso, performance, autobiografia nell'esperienza del cinema contemporaneo
Venezia, Marsilio, 2018, 114 pp., euro 10,00
ISBN 8831708287
|
|
|
«Ribaltare l’immaginario riproduttivo, storicamente associato al termine “documentario”, per attestarne l’essere forma artistica della contemporaneità» (p. 7). È questa l’emergenza alla base dell’ultimo lavoro di Marco Bertozzi: un nuovo tassello di un percorso già tracciato in due precedenti edizioni Marsilio, Storia del documentario italiano. Immagini e culture dell’altro cinema (2008), poi con Recycled cinema. Immagini perdute, visioni ritrovate (2013).
Se il proposito sembra essere «forse troppo ambizioso per un piccolo libro come questo» (p. 7) – come dichiarato dallo stesso autore –, Bertozzi riesce appieno nel suo obbiettivo declinando in un centinaio di pagine scandite in sei capitoli una pluralità di forme assunte dal documentario contemporaneo. Ne scaturisce una densa riflessione finalizzata a scardinare quelle istanze “identitarie” attraverso le quali il genere documentario è stato per lungo tempo letto.
Il metodo assunto da Bertozzi – in anni che hanno visto la sua attività di storico e teorico intrecciarsi con quella di filmmaker (si pensi a Cinema grattacielo, 2017) – coincide con un punto d’osservazione raro e al contempo palpabile: quello “dall’interno”. Abbandonata la veste “certificativa”, che lo voleva garante di una registrazione diretta del reale, il genere documentaristico disvela un’identità mutevole, quasi fluida, capace di lasciarsi plasmare, ma al contempo di dar forma a sua volta alle contemporanee fattezze assunte dall’arte.
Nel primo capitolo (L’ambiguo etimo della discordia) si definisce il documentario prima alla luce di un suo ribaltamento nel mockumentary, poi attraverso un progressivo slabbramento dei suoi confini verso gli orizzonti dei mediascapes, del found footage e del reenactment. Dalla pesante «eredità» di un «cinema diretto [, di] una visione convinta che la voce narrante possa essere solo voice of God, dunque didattica, didascalica, sin’anche autoritaria» (p. 26), trova il proprio punto di partenza il secondo capitolo (Disarmare la voce). Una visione che sin da subito cozza con le possibilità offerte dalla voice-over nel tessere un racconto di un’esperienza che, benché autobiografica, quindi soggettiva, garantita dalla forma dell’“io”, si apre potenzialmente ad abbracciare una «più vasta condivisione e appartenenza culturale» (p. 26). È così che riaffiora nuovamente il concetto di documentario smembrato nelle sue componenti al fine di declamare – in questo caso attraverso la propria voce – la confutazione di un’attribuzione identitaria di tipo mimetico.
Il terzo capitolo vede allora irrompere il «corpo dell’autore, della presenza viva e palpitante di atti performativi inscritti nel film» (p. 10): un corpo talvolta “vero” (come Mario Balsamo in Noi siamo come James Bond, 2012), talvolta mediato (come accade in My Winnipeg, 2007, di Guy Maddin, interpretato da Darcy Fehr), che non può che mostrarsi «nudo, in bilico fra il tentativo di guida del progetto e il suo epifanico accoglierne gli eventi» (p. 41). È allora al vasto orizzonte delle immagini nelle pratiche found footage che l’autore dedica il quarto capitolo (Cinegrafie del riuso), dove in uno spazio filmico espanso il cinema documentario si trova allora a dialogare con l’arte contemporanea. Nella molteplice possibile «modulazione dei sensi» trova il proprio posto l’opera di Alina Marazzi, recuperata sia nelle delicate sfumature delle immagini private di Un’ora sola ti vorrei (2002), sia attraverso «la mescolanza di materiali di repertorio [… di] un film meno intimo e più sociale come Vogliamo anche le rose (2007)» (p. 53). Ma non solo. Le pellicole vengono allora riportate a nuova vita, coinvolte nell’orizzonte di un Cinema Open: dagli esperimenti dell’Eye Film Institute di Amsterdam per la creazione di forme testuali partecipate remixate, a quelli sviluppati nel percorso intrapreso da Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna attraverso il progetto Expanded Archive. O ancora il recupero, il riuso e la rilocazione delle pellicole all’interno dei percorsi espositivi e museali, argomento sul quale trova la propria articolazione il quinto capitolo (Exhibiting cinema).
Infine, nel sesto e ultimo capitolo (Arcaico, opaco, italiano), Bertozzi volge lo sguardo verso le varie forme del documentario italiano. Qui La bocca del lupo di Pietro Marcello (2009) si offre allora come esempio di declinazione «di una speciale marca identitaria [del cinema italiano], che proprio nelle difficoltà dell’avvento di questa supposta condizione moderna riesce a evitare la compattezza di un unico paradigma estetico-filosofico, recuperando forme inesauste dagli orizzonti dell’arcaico, del magismo, del mito» (p. 86).
di Elisa Bianchi
|
 |
|
 |

|
 |
|
|
|