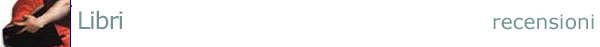|
Nel 1769, al giovane conte Vittorio Alfieri aveva dato oltremodo fastidio assistere alla «genuflessioncella d’uso» del Metastasio all’imperatrice Maria Teresa nei giardini di Schönbrunn: gli era parso che quella «Musa appigionata o venduta all’autorità despotica» fosse tutt’altro che degna di amicizia o familiarità, l’antitesi vivente all’idea di una poesia libera e salvifica. Il ritratto fugace dell’artista servilmente lieto e adulatore era davvero impietoso, benché attenuato da una certa dose di autocritica, se, rievocando quell’incontro occasionale, Alfieri parlava di sé come di un ventenne abituato a esagerare «il vero in astratto», «un tutto assai originale e risibile». Certo, fra il celebre e anziano maestro e il viaggiatore inquieto e promettente non vi fu alcuna comunicazione, né i loro mondi ebbero modo di confrontarsi, anche se per poche sere, fra le probabili scintille che un «salvatico pensatore» avrebbe creato al seguito della «fastidiosa brigata di pedanti» viennesi, tra cui spiccava l’ambasciatore del Re di Sardegna, il conte di Canale. Per imperscrutabili vie, strani dinieghi o ansie di identità, qualche volta historia facit saltus. E segna fratture profonde tra un’epoca e l’altra, con il suggello di episodi dalla forte carica simbolica.
Con il ricordo sprezzante del grande tragediografo calò il sipario su un’esperienza tra le più significative e complesse della civiltà settecentesca, non solo teatrale e musicale. Metastasio rimase marchiato a fuoco dalla sua qualità di poeta cesareo, intellettuale organico a una corte prestigiosa e a un orizzonte di valori transnazionali, interprete colto e attento – e fedele fin anche nella acuta percezione del crepuscolo – dei fondamenti istituzionali e dei codici di comportamento dell’ancien régime. L’eco dei suoi successi si affievolì lentamente in ogni latitudine d’Europa, ma l’età che si aprì all’indomani delle rivoluzioni tardo-settecentesche provò sempre maggiore insofferenza per una drammaturgia incomprensibile al di fuori del sistema ideologico-politico che l’aveva ispirata, smarrendo progressivamente ogni possibile chiave di lettura, ogni approccio meditato ed equanime. Sopravvisse – a tratti – il piacere di un’elegante facilità dei versi, guardata con un misto di sufficienza e sospetto (anche se tanta librettistica ottocentesca non sdegnò di riproporre immagini e stilemi, ammirata dalla loro perspicuità); gli interventi critici di Carducci e De Sanctis (sua la formula del «comico involontario») non valsero a produrre un’inversione di tendenza duratura, a riaccendere l’interesse per una figura avvertita come fredda, distante, e incapace di parlare ai contemporanei.
Occorreva forse l’esaurirsi della lunga stagione romantica perché cominciasse a dissiparsi questa spessa cortina di indifferenza e si tornasse a cogliere il disegno coerentissimo della poesia metastasiana, un dialogo ininterrotto con le tensioni della storia e le questioni del governo e del decoro, degli affetti e dei doveri, dietro l’apparente immutabilità di schemi lucidi. A poco a poco sono riemersi i valori di un “impegno” da decifrare, il prestigio di un “classico” che seppe dominare come pochi le sue scelte stilistiche e le sue convinzioni in funzione di una committenza materiale e immateriale. Di certo, era necessario che all’autore si dedicassero doti esegetiche non comuni, la capacità di padroneggiare gli strumenti dell’analisi letteraria, di ravvisare l’evolversi di una preparazione filosofica che vivifica e orienta il gusto del “dilemma” nelle varie trame disseminate nell’arco di cinquant’anni, l’attenzione alla sapienza con cui l’abile montaggio delle azioni, la scioltezza dei versi, il susseguirsi ragionato di recitativi e arie si misurano con i linguaggi tutti della scena. Rileggere le sue opere è una sfida sempre nuova e – soprattutto – uno sforzo di immersione in un milieu aristocratico scandito da rituali e dilaniato dalla fatica della sopravvivenza di fronte ai tanti pericoli che lo sovrastano, ma da lui ricomposto nella fede in una possibile, superiore armonia.
Della renaissance metastasiana nella seconda metà del Novecento Elena Sala Di Felice è stata protagonista indiscussa, non solo per la sagacia e la brillantezza di un percorso di studi complesso ed eclettico, in cui ha dato ampia prova del possesso di tutti quei talenti così particolari che l’impresa richiedeva, ma per la risolutezza del metodo, grazie al quale ha da subito individuato nella deprecata strumentalità di libretti, cantate, oratori (un elemento comunque imbarazzante per l’italianistica d’antan, anche nelle sue forme più illuminate) il punto di forza di un artista ex cathedra attraverso la rete inesauribile delle esecuzioni teatrali. Dopo una felice antologia di opere da lei curata per Rizzoli nel 1965, nel mezzo di una serie di contributi meritori che han provveduto a far luce sull’altezza d’ingegno dell’abate (tra i protagonisti della ricerca Claudio Varese e Walter Binni), è stato il volume Metastasio. Ideologia. Drammaturgia. Spettacolo (Milano, Franco Angeli, 1983) che ha consacrato la definitiva uscita di minorità dell’autore, elevato a interlocutore privilegiato di un momento irripetibile della civiltà europea. Senza questa ricostruzione impareggiabile dell’officina del poeta, vista nelle sue dinamiche intricate, tra elaborazioni concettuali, soluzioni espressive, proiezioni drammatiche ed extra-linguistiche, il fervore critico fra vecchio e nuovo millennio promosso dalle manifestazioni per il tricentenario della nascita sarebbe stato davvero inconcepibile.
Sogni e favole in sen del vero. Metastasio ritrovato parrebbe pertanto l’ultimo approdo di una passione scientifica di lunga durata, il desiderio di sistematizzare un’esplorazione a tutto tondo di un universo estetico e intellettuale, proseguita mediante ulteriori sondaggi e arricchimenti tematici per oltre un ventennio. Ma è tratto ammirevole della studiosa aver resistito alla tentazione del bilancio, e avere impresso alla prospettiva diacronica con cui si è allestita la raccolta di studi il segno di una progettualità. Questo libro poteva essere un discorso chiuso e autocelebrativo; è invece il cantiere di un monumento che si vuole incompiuto. Per continuare il viaggio personale, e per lasciare che continui – come era già successo al termine della fase pionieristica. Nella monografia trovano posto, ad apertura, due dei saggi epocali contenuti nel lavoro del 1983: è il tributo necessario a una rifondazione teoretica imprescindibile per capire perché e come ci si è riappropriati dell’exemplum Metastasio. L’ordine della parola (pp. 9-149) è un denso excursus nella produzione librettistica dove già il titolo è emblematico di un ribaltamento di prospettiva: sembra insistere sull’antico topos di una scrittura fluida, lineare, realizzata con mestiere, e in realtà quel che si indaga è la parola che ordina, che dirige, che regna sovrana nella dimensione inevitabilmente centrifuga di chi compone per il palcoscenico. È qui che si formula con chiarezza la nozione di logocentrismo: l’abate non rinuncia a credere e a difendere la supremazia della poesia fra le arti che concorrono al melodramma, in linea con le tesi prevalenti nella trattatistica coeva e con il magistero impartitogli in gioventù (anche se Gravina non amò fare concessioni alle seduzioni dello spettacolo), ma i suoi testi non disdegnano di misurarsi con le suggestioni della musica, della recitazione, della scenografia, al fine di riassorbire nel dettato verbale qualsiasi sviluppo prossemico e visivo. «Il testo, nell’ottica metastasiana s’intende, conteneva effettivamente la fabula agenda, era capace di generarla, o quanto meno pretendeva a tanto» (p. 27): è questa la via maestra a una riforma che non è sterile ossessione del primato del logos, o accanita soluzione delle tematiche convenienti e politically correct, si direbbe oggi, ma interazione della parola nella struttura polisemica dell’evento teatrale (e si rivelano utilissime le categorie semiotiche elaborate e messe a frutto tra gli anni Settanta e Ottanta).
L’esemplificazione è ricca e persuasiva, ed investe non solo il piano delle minuziose didascalie in cui l’autore inquadra la sua sempre calibratissima actio, ma anche l’impianto dialogico, così prodigo – a ben vedere – di indicazioni vincolanti per la resa scenica. L’ambizione del Metastasio alla poesia ordinatrice si evince tanto nel raffronto diacronico con gli stratagemmi del récit e della creazione di effetti del predecessore Zeno e del mentore Gravina, quanto nel gioco sincronico che si instaura con le realizzazione pittoriche dell’epoca (sul quale la studiosa sarebbe tornata nei testi Ut drama pictura. La muta eloquenza del Tiepolo e la facondia pittorica del Metastasio e La retorica tra drammaturgia, teatro e pittura, ristampati nel volume alle pp. 397-420 e 421-446) e con le professioni teoretiche o le riflessioni consegnate alle lettere private. Va da sé che il logocentrismo non esclude la musica, anzi: la cantabilità del verso non è il frutto di una vena lirica incontrollata e piana, ma è l’effetto di una difficoltà dissimulata, ampiamente illustrata nel saggio sulle Geometrie della grammatica nelle arie di Metastasio (pp. 339-367), concepito come omaggio ad una figura di riferimento preziosa per la Sala Di Felice, Mario Baratto. Discutendo della «nobile e larghissima fama […] tra entusiastica ammirazione da una parte, dall’altra invece sufficiente tolleranza, quali concessioni all’imperio delle mode e ai capricci dei cantanti» di arie e canzonette (p. 339), appare evidente che la costruzione fonico-sintattica dei libretti non ha mai nulla di casuale, mirando decisamente alla coesione fra momenti dialogici e lirici, alle iterazioni del significante, alla produzione di atti linguistici in cui la contemplazione degli eventi si fa, molto scaltramente, azione o auspicio dell’azione. Bisogna prendere atto che, ferme restando le innumerevoli manipolazioni cui i testi dell’abate furono sottoposti durante il Settecento, la musicologia ha recepito nelle sue analisi il forte grado precettivo che essi prospettano al compositore, provandosi a imporre, più che a offrire (secondo giudizi più soft), indicazioni sul crescendo emotivo e sul conseguimento del pathos.
L’arbitro dei destini, scritto per i settant’anni di Giuseppe Petronio e anch’esso trasmigrato dalla monografia del 1983 a Sogni e favole, assolveva e assolve tuttora una funzione complementare: se L’ordine della parola si sofferma sul Metastasio mediatore fra committente e destinatario in quanto uomo di spettacolo, qui il tema cruciale è la consapevole mediazione «fra il trono e i sudditi» che il poeta cesareo avoca a sé. La funzione arbitrale, così come definita da Etienne Souriau, non è però solo della figura regale, con l’ovvia ricaduta della creazione del consenso nei confronti del monarca assoluto, declinato in ogni possibile epifania: passa – per senso di missione e per adesione culturale – all’autore di quei progetti drammatici, arbitro di un ordo ideale da ribadire tra le vicissitudini del mondo, tra lo splendore delle virtù e le miserie del concreto agire terreno, il campo di forze dove rifulgono con diversa intensità la magnificenza del sovrano e l’onestà e la fiducia dei mortali. Ne consegue l’impossibilità di liquidare l’opera del poeta di corte come miope servilismo, secondo la visione post-rivoluzionaria, e, al contrario, l’obbligo di inoltrarsi nelle forme e nei modi che la dichiarata corresponsabilità con il potere costituito conobbe a partire dalle cantate dei primi anni Venti fino al Ruggiero del 1771.
La riproposta dei due testi evoca da un lato il culmine di una alacre fase di ripensamento sull’artista, dall’altro rilancia le argomentazioni cardine che in essi giungono a compimento, considerandole i postulati per ogni ulteriore avventura critica. Il logocentrismo e la sublime articolazione del consenso sono i punti di non ritorno dai quali si dipartono letture mirate e approfondite contestualizzazioni dell’opus cesareo, attraversato nella sua intrigante compattezza o scomposto nei suoi episodi salienti. Mi piace immaginare che al “plutarchizzante” Alfieri non sarebbe dispiaciuto confrontarsi con il “senechizzante” Metastasio de La clemenza di Tito, impegnato a far tesoro dei trattati morali del filosofo latino per incoraggiare l’imperatore in una contingenza politica molto delicata, come si racconta nel capitolo su Segreti, menzogne e coatti silenzi nella Clemenza di Tito (pp. 237-259). Il responso delle armi è sfavorevole, i dissensi interni minano la coesione necessaria a far fronte all’emergenza, ma l’impatto con la «rerum naturae altera pars» è solo uno snodo nevralgico in un itinerario ad virtutem che sarebbe imperfetto se lastricato unicamente di glorie e successi. La clemenza è l’approdo del monarca che «tutto sa, tutto assolve e tutto oblia», avvicinandosi in tal modo alla perfezione divina. Qui Elena Sala Di Felice modifica sensibilmente la chiave interpretativa di un altro benemerito studioso dell’abate, Jacques Joly, che aveva parlato della strategia dell’«inversione dei segni» ai fini della propaganda connaturata all’ufficio viennese. Metastasio non inverte nulla; semmai scava a fondo nella superficie della storia e in un immenso bagaglio culturale per connotare positivamente gli eventi, per offrire una luce in mezzo alle ombre. Il meglio di sé lo dà – come si rileva – nelle Lodi e lezioni per la corte (pp. 261-285), dove l’apologia e l’esaltazione sono anche il luogo per una riflessione sul fine didattico e mitopoietico dell’esempio melodrammatico, o nel «teatro come modello del mondo» realizzato sull’aspirazione di una simbiosi tra virtù e felicità (cfr. Virtù e felicità alla corte di Vienna – pp. 205-235), che è un’altra delle questioni essenziali affrontate dal poeta nei suoi testi.
Ma la prova decisiva di una inarrivabile raffinatezza metodologica è nei contributi dedicati alle Osservazioni sulla meccanica drammaturgica (pp. 175-203) e a Il desiderio della parola e il piacere delle lacrime (pp. 287-338). In entrambi l’indagine lessicale trapassa naturaliter nelle dinamiche della costruzione di senso dettate dalla scena e dai suoi quadri, e viceversa, mentre riflessioni etiche ed esistenziali sono condivise tra l’autore e il personaggio in una sapiente forzatura delle convenzioni del genere. Sullo sfondo v’è sempre un rapporto intenso, a tratti polemico, con il dibattito teorico contemporaneo, e sembra profilarsi un’assoluta modernità del Metastasio se si pensa al privilegio accordato alla sperimentazione sulla scena contro l’inaridirsi di ogni slancio espressivo nelle pagine di un trattato di poetica, genere al quale si dedicò tardi, e forse più per compiacere le mode dell’establishment intellettuale che per intima convinzione. La Poësie n’est pas un Art inutile dans la société, si legge nelle Réflexions critiques di Du Bos, autore noto al grande librettista ma mai esplicitamente citato, eppure verosimilmente fatto oggetto di lunghe discussioni con il Conte di Canale: la condivisione dell’idea secondo la quale l’arte si collega ad «un piacere a-razionale» non implica tuttavia che i termini della sua utilità non vadano rinegoziati alla luce «del potere conoscitivo, il quale non escludeva affatto quello della partecipazione emotiva» (p. 388). Non solo i classici, il saggio dedicato proprio a questo raffronto a distanza tra il francese e l’italiano (pp. 369-396), si inserisce idealmente in questa analisi complessa dell’opera drammatica, evidenziando i tratti di originalità, di rigore, di tensione programmatica da attribuire alla chiara, ardita riforma del Metastasio, che riuscirono a imporlo all’attenzione del suo tempo con una luminosità tale da offuscarne – da subito – una più segreta e affidabile intelligenza.
Del tutto inedito invece, in Sogni e favole, il decimo capitolo, quel Metastasio ritrovato che funge anche da sottotitolo al volume (pp. 447-560). La restituzione di un percorso scientifico maturato negli ultimi due decenni, modulata secondo nuovi scorci e angolature a suggerire altre visuali, con un montaggio insofferente al primato cronologico e tutto proteso alla valorizzazione delle tecniche di indagine, si distende in una cronaca fitta, puntuale della critica metastasiana dal dopoguerra ad oggi. E qui la studiosa spiazza decisamente il lettore: per sé ha dovuto privilegiare l’urgenza del metodo, per i suoi interlocutori (e s’intenda il termine nel senso letterale di figure che con lei hanno dialogato o si sono inoltrate nello studio di questo sommo testimone del Settecento) una scansione lenta, sinuosa, seguendo con dovizia di particolari il moltiplicarsi delle testimonianze e l’accrescersi dell’interesse intorno al poeta e alla sua opera. D’altronde, si trattava di un lavoro complicato: “oggettivare” una storia alla quale si appartiene interamente. Ed inesorabilmente. Dalle pagine trapelano le emozioni di una vita, la gratitudine (e la nostalgia) per incontri irripetibili, il compiacimento per il revival del tricentenario, la cui messe cospicua di atti ha una volta per tutte “riconosciuto” Metastasio nell’olimpo della nostra tradizione scenico-letteraria. L’occasione è preziosa per ridistribuire luci e ombre, disporre accenti, provare a tratteggiare un panorama fatto di sfondi e primi piani che oggi si percepiscono più chiaramente (affatto condivisibili sono, ad esempio, i meriti assegnati a Giovanna Gronda e Giuseppe Giarrizzo per aver opportunamente collegato il poeta cesareo alle temperie filosofiche e giuridiche del più fecondo Settecento, o il cammeo per Rosy Candiani e la sua sottile ricognizione delle stagioni degli anni Venti, quando la militanza tra i palcoscenici di Napoli, Roma, Venezia e l’assiduo contatto con musici e maestranze rinsaldò tenacemente il nesso fra teatro e letteratura), né manca uno sguardo pensoso al cantiere filologico gestito con professionalità e rigore da Anna Laura Bellina. Con una conclusione emblematica:
si sono constatate le iniziative volenterose di tanti giovani, portatori di nuove curiosità, aperti a nuovi metodi. […] Siamo convinti che i sentieri della critica si biforcano con non minore frequenza rispetto a quelli della creatività poetica, narrativa e anche drammatica; o – per restare in tema – dai rami più vecchi di alberi antichi se ne dipartono dei nuovi nel nostro giardino, che deve essere assiduamente coltivato, come raccomandava il voltairiano Martin. (p. 560).
Il nostro giardino, giustamente, che non è solo il comune campo di osservazione, ma un luogo che si sente proprio, e che si torna a coltivare quando altri semi e altre piante ne modificano l’aspetto. E si schermisce, Elena Sala di Felice, quando nella breve premessa presenta il libro come una «prova di lunga fedeltà cui guarderei con poca benevola autoironia» (p. 5). Sembra di leggere una di quelle frasi dell’epistolario metastasiano cariche di bonomia malinconica, e talvolta di autentico senso della difficile arte di stare al mondo. Sarà vero che ci scegliamo autori anche umanamente congeniali alla nostra indole, o che, nel tempo, tendiamo ad assomigliare a loro, come ad ineliminabili presenze del nostro spirito? Non è facile a dirsi. Di sicuro, ci sono studiosi vestali, custodi dei loro oggetti in un tempio sempre più inaccessibile, e padroni sorridenti e ospitali di insospettabili loci amoeni. Se c’è davvero una lunga fedeltà, è al dialogo, al ripensamento, all’apertura di nuove frontiere come habitus critico. È questo l’altissimo magistero racchiuso tra mille sogni e favole.
di Francesco Cotticelli
|
 |